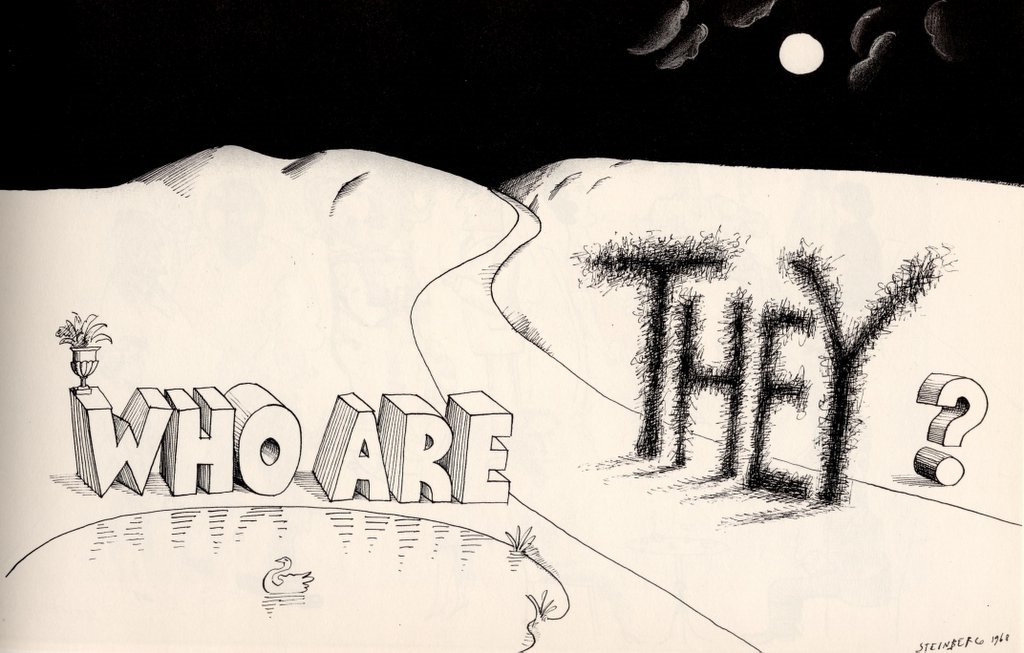«Che cosa fai nella vita?»
«L’antropologo culturale!»
«…»
Dopo la pausa canonica dell’interlocutore, le risposte possono variare:
«Ah, bello. Che lavoro affascinante!», se non si vuole rischiare di offendere la sensibilità di chi ha “sgobbato sui libri” come tutti coloro che hanno raggiunto l’agognato traguardo della laurea. Altri, più pragmatici e diretti, chiederanno: «…E che cosa fai? Dove lavori? Ecc.»
Dialoghi romanzati, quelli precedenti, forse misti ad esperienze personali ma che non si discostano molto da ciò che può realmente accadere. La domanda è legittima.
Cosa fa un antropologo culturale? Qual è la sua funzione?
L’antropologo culturale cerca di intavolare un discorso sugli uomini e sulle attività che li vedono impegnati, in modo individuale e collettivo, all’interno di un determinato contesto.
L’uomo si distingue dal resto delle creature che popolano la terra per una caratteristica fondamentale: la cultura. Questo è il suo “strumento” basilare per garantirsi la sopravvivenza. Come afferma Marco Aime «la cultura è alla base della nostra vita. Determina il nostro agire quotidiano, così come ha modellato i nostri corpi nel corso dell’evoluzione». La cultura è quindi per l’uomo come l’acqua per il pesce ed è la “materia” che l’antropologo tenta di indagare. Essa stabilisce il dentro e il fuori, determinando anche i canoni di normalità e di anormalità, «naturalizzandoli», come direbbe Marcel Mauss, rendendo istintivi e spontanei comportamenti e modi di intendere il mondo e le relazioni. Una “materia” che è variabile, che assume forme, caratteristiche e funzioni diverse a seconda dei contesti umani in cui lo studioso svolge le sue ricerche.
Ogni gruppo umano si dota di cultura per “dare forma” al mondo, per determinare il senso e la ragione di tutte le cose e quindi dell’esistenza stessa del gruppo e di ogni individuo che lo compone. Tra le caratteristiche c’è quella di essere un contenitore di principi socialmente riconosciuti che trasmette senso di “stabilità” ed “immutabilità” ma che, al tempo stesso, si dimostra molto fluido e permeabile alle modifiche.
L’antropologo va ad interessarsi proprio di quei meccanismi culturali che vengono assimilati da chi vive un determinato contesto sociale, e regolano ogni aspetto della vita per un gruppo. In questo modo egli mette in evidenza le differenze che intercorrono tra diverse culture, non per incasellarle in un’ipotetica scala gerarchica ma per offrire il suo contributo a quell’incessante opera di comprensione dei differenti modi di essere uomini.
Dopo questo sintetico excursus, una domanda è d’obbligo da parte dell’antropologo:
«Secondo voi, in un’epoca in cui l’argomento dei dibattiti internazionali spesso è legato agli spostamenti di gruppi di persone da una parte all’altra del globo, spesso per fuggire da scenari di guerra e persecuzione che hanno reso inospitali i luoghi in cui la loro identità culturale si è prodotta, quanto è determinante una figura che insegna e sensibilizza su come relazionarsi con l’alterità di cui questi migranti sono portatori?» Stimolare la “sensibilità collettiva” alla relazione ed il confronto costruttivo ed integrativo, alla comprensione di ciò che è altro dal “nostro modo” di concepire il mondo, è un aspetto fondamentale della prospettiva antropologica.
Una prospettiva figlia di una disciplina che, a differenza delle scienze dure (hard science) si pone l’obiettivo di studiare in modo “sistematico” gli aspetti della complessità umana, per nulla replicabili in un laboratorio.Una disciplina che scova e descrive le differenze culturali per mettere a nudo il loro carattere costruito, non naturale e diminuire quella estraneità che si avverte nei confronti di chi esiste e pensa secondo altri codici ed altre modalità.
Come affermava il commediografo latino Terenzio «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» (Sono un uomo e nulla che sia umano mi è estraneo).
Bibliografia
Aime, M. (2013), Cultura, Bollati Boringhieri, Torino,
Mauss, M. (1936), Le tecniche del corpo
Terenzio, (165 a.C.), Heautontimorùmenos (Il punitore di se stesso), v. 77