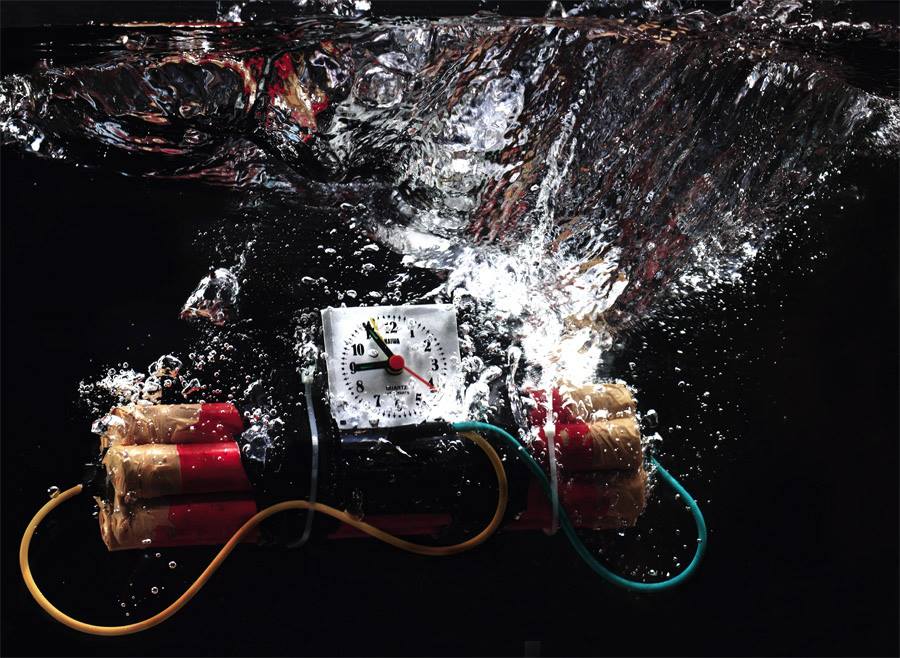Afghanistan, Libia, Francia, Stati Uniti, Burkina Faso, Indonesia, Turchia, Camerun e Pakistan, sono solo alcuni dei paesi colpiti da attacchi terroristici dal 2001 ad oggi.
Il fenomeno del terrorismo ha ormai assorbito la natura globalizzata della società moderna, sfruttandone opportunità e sistemi di comunicazione. Grazie alla fitta rete di cellule dormienti, i terroristi possono colpire in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza distinzioni tra bianchi e neri, cristiani e musulmani, civili o militari. Le grandi città si stanno trasformando in veri e propri presidi militari permanenti, che se da un lato possono aumentare il nostro senso di sicurezza, dall’altro evidenziano la sfumatura ansiogena della quotidianità civile.
Una delle sfide più grandi della società contemporanea, e quindi anche della comunità scientifica, è quella di comprendere la minaccia terroristica al fine di sconfiggerla.
Dall’analisi dei fattori psicologici coinvolti nella radicalizzazione (ne abbiamo parlato qui) , si possono trarre alcune conclusioni che permettono di prevedere importanti strategie per contrastare tale fenomeno.
Il terrorismo si sviluppa secondo diversi fattori psicologici posti su tre livelli interdipendenti. Il livello individuale, che contribuisce a creare le giuste motivazioni e la dedizione per sostenere le cause del terrorismo, il gruppo, che opera l’indottrinamento e la formazione tramite la pressione sociale e le credenze ideologiche, e l’organizzazione che crea i meccanismi, le strutture e le ricompense necessarie alla sopravvivenza del gruppo. Insieme, questi tre livelli di processi psicologici operano di concerto per promuovere la cultura di una psicologia del terrorismo. (cfr. Kruglanski & Fishman, 2009).
Ma come sono state sfruttate, ad oggi, queste conoscenze nei diversi Paesi? Quali azioni concrete sono scaturite dalla comprensione del fenomeno della radicalizzazione? E infine come deve porsi la Psicologia per suggerire le soluzioni più adeguate ed efficaci?
Il 22 aprile 2008, Il Peace Institute e il Ministero degli Affari Esteri Norvegese hanno ospitato una conferenza internazionale a New York dal titolo “Leaving terrorrism behind: Individual and collective disengagement from violent extremism”. Durante la conferenza Fink e Hearne (2008) hanno evidenziato che i processi di deradicalizzazione hanno importanti elementi in comune con quelli della radicalizzazione e che di fatto ne costituiscono una “immagine speculare”. Così, Partendo da questa considerazione si evince che: “nello stesso modo in cui la radicalizzazione può far emergere la motivazione per aderire ad una ideologia violenta, giustificandola come violenza commessa per una giusta causa, la deradicalizzazione può far emergere la motivazione per abbandonare una tale ideologia e favorire la ricerca di percorsi alternativi che siano importanti e con un forte significato personale”. (Kruglanski & Fishman, 2009)
Secondo questa analisi, sia la radicalizzazione che la deradicalizzazione coinvolgono due elementi essenziali:
- l’elemento intellettuale o cognitivo, che risiede nei contenuti dell’ideologia;
- l’elemento motivazionale, che consiste nell’accettare l’ideologia violenta o respingerla.
In effetti, i vari programmi di deradicalizzazione considerano e sfruttano uno o entrambi questi elementi nel tentativo di dissuadere gli individui dal continuare ad aderire all’ideologia terrorista.
Pertanto, questi programmi affrontano gli elementi intellettuali della deradicalizzazione attraverso l’arruolamento di autorità religiose, riconosciute all’interno del panorama musulmano, che possano mettere in discussione le interpretazioni jihadiste del Corano, dandone quindi una interpretazione alternativa. La componente motivazionale invece viene affrontata fornendo ai singoli individui e alle loro famiglie le possibilità e i mezzi necessari per ritagliarsi uno spazio all’interno della società, favorendo l’integrazione e la conquista di un forte significato personale all’interno delle comunità, anche attraverso mezzi materiali ed economici (Ibidem)
Recentemente, importanti sforzi di deradicalizzazione sono stati avviati in diversi paesi, tra cui Singapore, Arabia Saudita, Egitto, Yemen, Iraq, Malesia e Indonesia. Uno dei programmi che ha avuto maggior successo è quello Egiziano, iniziato nel 1997 quando i capi del Gruppo Islamico (IG), dopo essere stati catturati rinunciarono all’ideologia jhiadista. (cfr. Stracke, 2007). Il programma Egiziano sfruttava gli argomenti che causarono la deradicalizzazione del Gruppo Islamico, fornendo anche una borsa di studio e lavoro a coloro che entravano nel programma. Infatti i leader di IG hanno prodotto circa 25 volumi chiamati Tashihal-Mafahim (correzioni dei concetti), contenenti argomenti razionali e teologici per sostenere un’interpretazione islamica moderata, denunciando l’uso della violenza contro civili, stranieri e musulmani moderati, condannando definitivamente l’estremismo ideologico e violento. (cfr. Black, 2007). Allo stato attuale, il programma sembra aver avuto grande successo e gli attacchi terroristici attribuiti a IG sono cessati. (cfr. Ashour, 2008)
Analizzando il fenomeno terroristico da un punto di vista psicosociale, fondamentale potrebbe essere la creazione di una realtà condivisa, all’interno dei gruppi musulmani, che si opponga alla ideologia più estremista. Come sosteneva Lewin più di mezzo secolo fa, i tentativi di persuasione che si concentrano esclusivamente sul singolo, possono essere meno efficaci e più suscettibili alla recidiva rispetto a quelli diretti verso un importante gruppo di riferimento per l’individuo. Per esempio, lo sforzo volto alla deradicalizzazione di terroristi detenuti potrebbe non durare nel tempo, se questi vengono poi rilasciati nelle loro vecchie reti sociali entrando nuovamente in contatto con vecchi atteggiamenti e credenze.
Dal punto di vista organizzativo, il terrorismo può essere considerato come un potente strumento tattico per il raggiungimento di specifici obiettivi, che permette anche alle piccole organizzazioni di sviluppare un enorme potenziale offensivo e imprevedibile. Tenere conto anche di questo aspetto significa tentare di persuadere l’organizzazione terroristica che:
(a) questo mezzo particolare è inefficace dati gli obiettivi dell’organizzazione;
(b) esistono mezzi alternativi è più efficaci ai fini dell’organizzazione;
(c) il terrorismo in realtà costituisce un ostacolo al raggiungimento di altri importanti obiettivi.
Bisogna però tenere presente che questa concezione (terrorismo = strumento) varia da organizzazione a organizzazione. Secondo Gunaratna (2002), infatti gruppi islamici più estremi mostrano un totale adesione all’ideologia terroristica, il che impedirebbe qualsiasi tentativo di dialogo o mediazione. La situazione è diversa per le organizzazioni che considerano il terrorismo uno strumento da utilizzare solo in determinate circostanze.
Le organizzazioni come Hamas, Hezbollah, o Sin Fein, per esempio, anche se difficilmente possono essere indotte a rinunciare all’utilizzo del terrorismo, hanno altri mezzi a loro disposizione (diplomazia, campagne di stampa), così come altri obiettivi (di natura politica o sociale). Questo ha portato a concludere che: «mentre negoziare con le organizzazioni il cui impegno al terrorismo è totale e incondizionato è improbabile, potrebbe invece funzionare con quei gruppi terroristici che possono valutare mezzi alternativi per raggiungere i propri obiettivi» [Kruglanski & Fishman, 2009]
Le politiche di contro-terrorismo come gli “attacchi mirati”, basate sull’utilizzo delle cosiddette bombe intelligenti spesso causano “danni collaterali” (vittime civili), attivando il desiderio di vendetta e amplificano la componente emozionale e motivazionale che spinge gli individui ad arruolarsi tra le fila dei jhiadisti (cfr. Atran, 2003). Una recente analisi empirica infatti suggerisce che i “colpi mirati” da parte delle forze israeliane hanno causato l’aumento del reclutamento tra le fila dei terroristi, presumibilmente a causa della maggiore motivazione dei palestinesi nel voler vendicare i compagni caduti. A questo proposito, la ricerca ha scoperto che utilizzando dei metodi meno violenti, ad esempio arrestare le persone sospettate di terrorismo invece che ucciderle, tendevano a ridurre anziché aumentare il reclutamento (cfr. Kaplan, Mintz, Mishal, & Samban, 2005).
L’essenza psicologica del terrorismo offre preziosi suggerimenti per pianificare delle strategie efficaci nella lotta al terrorismo. Queste ultime, tuttavia, devono essere pianificate con molta cautela: se da un particolare livello di analisi possono apparire efficaci, ad un altro livello possono rivelarsi tutt’altro. Per esempio, l’uso della forza militare contro obiettivi strategici mirati può effettivamente minare la capacità offensiva di un’organizzazione, ma nello stesso tempo la comunità colpita dai danni collaterali può reagire sviluppando sentimenti di rabbia e vendetta causando un aumento del reclutamento tra i terroristi. Negoziare con un’organizzazione terroristica può servire a comunicare che esistono mezzi alternativi per il raggiungimento dei propri obiettivi, riducendo quindi la tendenza dell’organizzazione ad intraprendere azioni violente. Eppure, negoziare con i terroristi può trasmettere anche il messaggio che il terrorismo sia una tattica efficace, favorendone l’utilizzo futuro.
In conclusione, la psicologia a supporto dell’antiterrorismo deve essere consapevole di questi compromessi e suggerire soluzioni integrate da porre come basi per le politiche sulla prevenzione e lotta al fenomeno terroristico.
Leonardo Caramazza
Bibliografia
Fink, N. C., & Hearne, E. B. (2008). Beyond terrorism: Deradicalization and disengagement from violent extremism. In International Peace Institute, 1–27.
Kruglanski, A. W., & Fishman, S. (2009). Psychological Factors in Terrorism and Counterterrorism: Individual, Group, and Organizational Levels of Analysis. In Social Issues and Policy Review, Vol. 3, No. 1
Stracke, N. (2007). Arab prisons: A place for dialogue and reform. In Perspectives on Terrorism, 1(4).
Ashour, O. (2008). De-radicalization of Jihad? The impact of Egyptian Islamist Revisionists on Al Qaeda. In Perspectives on Terrorism, 2(5)
Black, I. (2007). Violence won’t work: How author of ‘jihadists’ bible’ stirred up a storm. In The Guardian.
Atran, S. (2003). Genesis of suicide terrorism. In Science, 299
Kaplan, E., Mintz, A., Mishal, S. & Samban, C. (2005).What happened to suicide bombings in Israel? Insights from a terror stock model. In Studies in Conflict and Terrorism, 28
Gunaratna, R. (2002). Inside Al Qaeda: Global network of terror, New York: Columbia University Press.